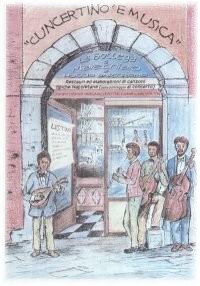|
Vi sono alcune attività ed alcuni mestieri che, attuali e diffusissimi in
una determinata epoca e in un particolare contesto, finiscono col
deperire poco a poco per poi sparire quando vengono a mancare le ragioni
per le quali hanno attecchito.
Napoli, ovviamente, in virtù della fantasia dei suoi figli e della
secolare ed affinata arte di arrangiarsi, ha visto nei secoli, nascere,
fiorire e decadere centinaia di professioni esercitate da personaggi
strani non per loro stessi, ma per le attività, a volte geniali, a volte
addirittura truffaldine, che svolgevano.
Voglio ricordarne alcune che, diffuse ai tempi della mia fanciullezza,
sono oramai sparite, affinché, ricordandole, i futuri figli di Partenope
possano sorridere dei loro padri ed apprezzarne la genialità.
Franco Celentano |
|
 |
|
OLIANDOLO A
DOMICILIO
Oggi l’olio si vende in
bottiglie, di solito di 75 cl.
Qualcuna è da un litro, pochissime hanno
misure diverse.
Recentemente sono andato in perlustrazione ed ho potuto costatare
che i rivenditori d’olio sciolto ed in lattine sono, ormai, una
sparuta pattuglia e che sono costretti a condurre una vita magra.
Oggi c’è la televisione che fa la propaganda e noi non possiamo
competere!
Volendo essere
onesti, dobbiamo ammettere che il commercio dell’olio sciolto è
tramontato quando opportune leggi hanno reso impossibili, o quasi,
manipolazioni o sofisticazioni.
Oggi l’olio è sottoposto a controlli abbastanza severi, è stato
analizzato, catalogato, suddiviso per qualità e, forse
ingiustamente, criminalizzato come tutti gli altri grassi.
Sappiamo che può essere extra vergine con premitura a freddo, extra
vergine con premitura a caldo, vergine, d’oliva, di sansa, di semi,
di soia, di girasole, d’arachidi e… d’ignote origini.
Fino a qualche anno fa ogni famiglia aveva il suo oliandolo al quale
si affidava e che gli propinava il “suo olio”.
Andava in giro con un otre e con, attaccate alla cintura, le varie
misure da un misurino, due misurini e così via.
Un misurino era un decilitro e le misure, che erano d’alluminio,
sono oggi in pratica scomparse.
Solo per un invito al ricordo: oggi mandare un bambino a comprare un
misurino d’olio sarebbe impensabile, quando il bambino ero io, era
la regola!
La sua merce era destinata sia per condire alimenti sia per
rifornire le lucerne che illuminavano bassi e Tabernacoli.
Era una mistura a volte verde
scuro, a volte chiarissima ed il suo sapore variava dal gradevole al
nauseante.
Tutto era
affidato alla coscienza di questo professionista che, probabilmente,
aveva anche qualità d’alchimista e che elargiva consigli sia sulla
quantità che sulla qualità da adoperare per le diverse esigenze.
C’era l’olio per l’insalata, da utilizzare cioè a crudo, l’olio per
la frittura, di dubbia provenienza, e quello per cucinare.
E’ giusto far rilevare, in ogni modo, che quest’ultimo tipo era poco
usato perché in cucina si preferivano il lardo e la sugna, che era
fatta in casa con un procedimento che dava, come sottoprodotto (e
che sottoprodotto!), ” i cicoli”.
Nella cucina
napoletana è in pratica ignorato il burro.
Lardo, sugna, loro derivati e grassi animali in genere sono oggi,
purtroppo criminalizzati perché deleteri per l’equilibrio lipidico
e, pertanto, banditi da tutte le diete.
Rivolgendosi ad una clientela povera, l’oliandolo vendeva
comunemente a credito fissando il limite di questo in ragione delle
possibilità economiche, reali o anche solo potenziali, del cliente.
|
|
L'ARROTINO
Non è un mestiere
esclusivamente napoletano, ma a Napoli, naturalmente, si è colorato
dell’inventiva e della fantasia proprie del popolo dei vicoli.
L’arrotino aveva un posto fisso, ‘o posto ‘e l’arrutine, ma non
disdegnava di andare in giro per i vicoli col suo trabiccolo che era
un esempio d’elementare, ma geniale tecnica.
Il citato trabiccolo aveva una sola ruota, come le carriole, e i
piedi potevano, all’occorrenza, diventare le impugnature necessarie
per spingerlo ed era munito di un pedale che, tramite una puleggia,
faceva girare la ruota di pietra abrasiva che era lubrificata
dall’acqua che gocciolava da una lattina sospesa sulla mola stessa.
La macchina, nata in legno, poco a
poco si trasformò perché, seguendo l’evoluzione dei tempi, fu
adottata una bicicletta opportunamente modificata, ma anche dopo
questo doveroso omaggio alla modernità, il principio sul quale si
fondava rimase inalterato.
L’unica differenza sostanziale fu che la pietra per affilare, o
mola, era azionata mediante i pedali della bicicletta.
Alcuni arrotini, particolarmente raffinati, avevano due mole, una
grossolana e l’altra più fine destinata ai lavori più delicati o ad
affinare quanto abbozzato con la mola precedente.
La macchina era completata da una robusta cinghia di cuoio
utilizzata per “rifinire” il lavoro fatto ed eliminare i segni
lasciati sul metallo dalla pietra abrasiva.
Una cinghia, per
intenderci, simile a quella adoperata dai barbieri quando affilano
il rasoio.
Ancora oggi accade di ascoltare la vecchia, prolungata chiamata “ammola-forbici”,
ma ciò accade sempre più di rado perché nei mercatini rionali, i
coltelli sono venduti a pochi centesimi di euro mentre, quando io
ero ragazzo, chi possedeva un coltellino era invidiato da tutti i
coetanei del quartiere.
Recentemente ho costatato che i vecchi arrotini si sono aggiornati
nel tentativo di “riciclarsi” sottoponendo ai potenziali clienti
tutta una serie di servizi che comprendono quello antico di “ammola-forbici”.
Oggi promettono di sturare gli ugelli delle cucine a gas, di
riparare piccoli guasti agli elettrodomestici ed all’impianto
idraulico.
Promettono molto e, a quanto ho potuto verificare di persona,
mantengono poco.
E a prezzi da capogiro.
|
| |
'O CUNCERTINO
In questi ultimi
tempi, in compagnia di tante altre cose, è stato confinato in
soffitta anche il corteggiamento o, per essere più puntuali, il modo
tradizionale, utilizzato per secoli, per comunicare ad una donna i
propri sentimenti.
Sempre più spesso, in verità, sono le ex dolci pulzelle a prendere
l’iniziativa in maniera sbrigativa rimettendoci, a mio avviso,
moltissimo.
Oggi è di moda la proposta esplicita, fatta sempre più di frequente
con uno sms conciso ed ultimativo che chiarisce immediatamente i
termini di una transazione che somiglia sempre più ad un contratto.
Giusto, sbagliato?
Non è certamente questa la sede per disquisire su un argomento
apparentemente frivolo, ma d’enorme importanza.
Questo nuovo approccio ha, però, strangolato un’attività antica di
secoli, cantata dai poeti ed oggetto di mille canzoni: ‘o cuncertino.
Giulietta e Romeo sono stati relegati, con il loro verone,
nell’album dei ricordi e Edmond Rostand, con il suo Cyrano de
Bergerac è diventato un inguaribile imbranato imbevuto di concetti
superati e proprietario di un disgustoso vocabolario trasudante
parole mielose.
La luna ha subito l’onta del piede umano ed ha smesso d’essere la
silenziosa complice di parole sussurrate o cantate sommessamente con
l’aiuto di un’altra, tradizionale complice degli innamorati: la
chitarra.
Oggi fanno sorridere usanze che fino a pochi anni fa erano parte
essenziale della cultura e della tradizione del nostro popolo.
Le dichiarazioni “serie” dovevano essere pubbliche ed il vicolo
tutto doveva sapere che Gennarino amava Carmela, gli onomastici
dovevano essere festeggiati in compagnia ed era,
quindi, giustissimo far rivolgere
al festeggiato un affettuoso, caratteristico, irridente augurio.
Si appaltava ‘o cuncertino.
Un paio di chitarre, un mandolino, un ragazzo con una gran voce, la
luna: ecco gli ingredienti della ricetta.
Auguri e fior di rose... ascesse qualche cosa?
Auguri pe’ senza niente... ma vuie fusseve fetienti?
Per le fanciulle, parole magiche, che facevano rimescolare il
sangue, ascoltate in silenzio da un vicolo in ansia, che aspettava
trepidante la tanto desiderata risposta.
Si duorme o si nun duorme,
bella mia,
siente pe' nu mumento chesta voce!
Chi te vo' bene assaje sta mmiez'a via
pe te cantà 'na canzuncella doce!
Ma stai durmenno, nun te si' scetata,
'sti ffenestelle nun se vonno aprì.
E' 'nu ricamo 'sta mandulinata!
Scetate, bella mia, nu cchiù durmì!
In un mondo nel quale regnava
ancora l’economia e la società del vicolo, anche i malintesi, gli
immancabili litigi tra innamorati dovevano avere una “riparazione”
pubblica, come si può facilmente arguire gustando i versi del grande
Libero Bovio.
Serenatella sentimentale
c''o ppoco 'e luna ca vo' sentì,
sceta a chi dorme, scòrdate 'o mmale,
torna 'a fa' pace, c'aggio tuort'i'!
Sona, chitarra, sona
t'è rummasa 'na corda:
si pur'essa se scorda
fernisce 'e sunà.
Infine, le argomentazioni di un
guappo che, in quanto tale, non può piangere e che lascia questo
compito al concertino che, tanto per cambiare, è suo compagno e
complice:
L'aggio purtato 'o capo cuncertino
po' sfizio e me fa' sentere cantà
m'aggio bevuto 'nu bicchiere 'e vino
pecchè stanotte 'a voglio 'ntussecà!
Per una forma di “pari
condizione”, dopo aver citato Ferdinando Russo e Libero Bovio, mi
corre l’obbligo di ricordare il grandissimo di Giacomo, autore di
una “Serenata Napulitana” nella quale rifulge tutta la sua bravura:
Fresca è 'a notte: 'na luna d'argiento
saglie 'n cielo e cchiù ghianca addeventa,
e 'nu sciato, ogne tanto, d''o viento
mmiez'a st'aria se sente passà ....
Ah, che notte, ah, che notte! ....
Ma pecchè nun t'affacce?
Anche io ho fatto parte di un
concertino, prima come cantante, poi come cantante e chitarrista.
Ho festeggiato onomastici, ho chiesto la mano di ragazze felici e di
giovani infastidite e recalcitranti.
Ho visto lanciare dai balconi mazzolini di fiori e cose meno
romantiche.
Ho chiesto perdono ed urlato un dolore che non mi apparteneva, ho
chiamato a testimoni Santi
sconosciuti ed ho fatto giuramenti dei quali non dovevo rispondere
in prima persona.
Nel mese di maggio ho partecipato ai “Sabati della Madonna”, cantati
ed urlati per rispettare un voto fatto da un fedele stonato o privo
di una voce adeguata.
Il compenso?
Qualche lira, un pacchetto di sigarette.
Qualche volta un’effimera quanto gradita notorietà: chillo è d’o
cuncertino!
Ora i concertini sono finiti e ne sono quasi contento perché, ad un
certo momento della mia vita, ho dovuto smettere.
Per moltissimi motivi, nessuno dei quali gradevole.
|
| |
|
'A NUTRICCIA
Oggi il problema dell’allattamento
non esiste, anzi le donne, anche se ampiamente fornite di latte, fanno
ricorso sempre più frequentemente a quello artificiale.
Lo fanno per comodità, per non sciupare il seno e perché devono
recarsi al lavoro.
Che sia un bene o un male non spetta a me
|
 |
dirlo.
Fino agli anni ’50, invece, non avere latte era un’autentica disgrazia
ed era necessario ingaggiare ‘na nutriccia (una balia).
In virtù del loro seno prosperoso, erano preferite le ciociare ed
erano facilmente riconoscibili, oltre che per le caratteristiche
fisiche appena citate, per l’abbondanza di ori che ostentavano.
I genitori che erano costretti ad affidarsi ad una nutriccia, infatti,
0per ingraziarsela e per assicurare al loro pargolo un buon
trattamento, erano di solito molto prodighi ed elargivano a piene mani
costose “attenzioni”.
Logicamente, le nutrici erano sottoposte ad assidua sorveglianza
perché eventuali loro eccessi potevano incidere sulla qualità del
latte con il quale il rampollo era cibato.
La balia non doveva fumare (ma all’epoca erano poche le donne del
popolo che lo facevano), non doveva eccedere con l’alcol, non doveva
mangiare cibi indigesti, non doveva andare a letto tardi…
Non doveva litigare, non doveva arrabbiarsi perché il latte di una
donna arrabbiata si “inacidiva” e danneggiava il pargolo.
Insomma, doveva condurre una vita quasi monacale.
Lo facevano?
Di solito erano ospiti dei genitori del bambino, ma le famiglie meno
abbienti affidavano, spesso, il piccolo alla nutriccia che lo allevava
come un suo figlio fino a quando non si svezzava.
Nasceva perciò, spesso, un tenero rapporto, che durava tutta la vita,
tra queste prosperose donne di campagna ed i bambini che avevano
allattato che, spesso, conservavano anche da adulti l’accento ed il
dialetto del paese della loro “Tata”.
Non di rado nasceva, addirittura, una sorta di gelosia e di
competizione tra la mamma e la nutriccia e la letteratura del secolo
scorso ha tratto notevoli spunti da questi contrasti e dalle vicende
ad essi legati.
Il mestiere di nutriccia, in effetti, coinvolgendo i sentimenti, era
un mestiere difficile perché una donna raramente dimentica un bambino
che ha stretto al seno ed al quale ha dato il proprio latte.
Per concludere, voglio ricordare come era chiamata la nutrice dal
popolino che, nella sua semplicità, riesce di solito a cogliere e
sintetizzare meglio dei letterati situazioni e sentimenti:
mammazezzélla. |
|
'A MPAGLIASEGGIA
Cos’è oggi una sedia?
Basta fare un giro di primo mattino per vedere sedie a volte in ottimo
stato delle quali i proprietari hanno deciso di disfarsi
depositandole, con antica inciviltà, accanto ai secchioni
dell’immondizia.
Fino a qualche tempo fa, in ogni casa c’erano le sedie buone, che, di
solito, venivano ricoperte di canovacci per preservarne la
tappezzeria, e le sedie giornaliere o, se preferite, le sedie da
cucina.
Queste avevano il fondo di sala intrecciata, erano grezze e realizzate
artigianalmente e, logicamente, erano soggette ad usura.
Specialmente nelle case dove c’erano bambini abbondavano le sedie
sfondate!
Buttarle? Neanche a pensarci!
Quando il fondo cedeva, ci pensava ‘a mpagliaseggia.
Era una donna dall’età indefinibile che, con un fascio di sala sotto
il braccio e munita di un certo numero di spruoccoli, si aggirava per
i vicoli dando la caratteristica voce.
Operava, logicamente, in strada e spesso la sua opera era seguita con
interesse e commentata dall’intero vicolo.
Quando era richiesta la sua opera, prelevava le sedie e, dopo averle
trasportate all’aperto, eliminava la paglia che aveva costituito il
fondo della sedia da riparare e, servendosi di un coltellaccio e di
una stecca, provvedeva a
ricostituire il fondo della sedia.
A volte, quando l’ossatura della sedia aveva bisogno di qualche
rinforzo, si rivolgeva ad un altro personaggio, ‘o masterascio,
trasposizione dialettale di “Mastro d’ascia”, falegname.
Nei casi meno gravi provvedeva da sola utilizzando lo zoccolo come
martello.
Il connubio tra ‘mpagliaseggia e masterascio era così frequente che,
spesso, i due personaggi convolavano a giuste nozze mettendo in essere
una minuscola impresa a conduzione familiare.
‘O vascio, nota canzone dell’ultimo dopoguerra, firmata dal
solito E.A.Mario, trae proprio spunto da questa realtà recitando:
No, ‘stu vascio
nun è vascio:
è ‘na
reggia, ‘a meglia reggia…
E sissignore: ‘o pate è masterascio…
E sissignore: ‘a mamma è ‘mpagliaseggia…
Ma hanno fatto chella figlia
ch’è ‘na vera meraviglia
ca pe’ sbaglio è nata llà!
Il Signor tutto
(così era apostrofato E.A.Mario), in verità, sembra ribadire, nella
circostanza, che riparare sedie non era l’unica specialità della
accoppiata ‘mpagliaseggia-masterascio che, quando si impegnavano in
altre, più piacevoli attività, riusciva ad ottenere splendidi
risultati.
Il compenso?
Oggi l’opera di due artigiani avrebbe un costo proibitivo e tale
constatazione giustifica la scelta di molti che, anziché riparare le
cose, decidono di buttarle e di comprarne di nuove alimentando il
consumismo, malattia di questo secolo.
Allora, invece…
Allora una sedia aveva un valore intrinseco che conservava nel tempo.
Basta osservare il prezzo di una sedia antica…
Ripararla, in ogni caso, non era un problema: Signori, al vostro
buon cuore…
Altri tempi! |
|
|
|
|
|
'O PASSALAVE
Napoli è , per definizione, ‘o
paese d’o sole ed è forse questo il motivo per cui i governanti,
autarchici o di importazione, che si sono avvicendati nei secoli, non
hanno mai preso in seria considerazione le conseguenze che un
temporale può provocare in una città antica e dalle strade strette e
scoscese.
E’, perciò, antica tradizione
napoletana elencare, ad ogni cambio di stagione, danni e disastri
causati dagli immancabili allagamenti sopravvenuti con le prime
piogge.
Dissesti e danni da tutti deprecati ed ai quali, da sempre, nessuno
pone rimedio.
Dissesti così antichi che hanno, oramai, nome e cognome.
La lava ai Vergini, per esempio, è il tradizionale allagamento di
questo quartiere nel quale confluisce l’acqua che precipita dalla
collina di Capodimonte attraverso antichi canaloni e che,
puntualmente, trova intasate le fogne che nessuno si è curato di
spurgare.
Essendo, quindi, un avvenimento vecchio di secoli, è atteso oramai da
tutti come un vecchio, anche se sgradito, amico e, segna, di solito,
la fine dell’estate.
Ancora oggi i vecchi della Sanità, per dire che questa stagione non è
ancora finita, usano la frase ascoltata in tempi remoti dai loro
padri: Non è venuta ancora la lava ai Vergini.
Bassi pieni di melma, materassi messi ad asciugare nei vicoli.
Buche, voragini, qualche morto per cause accidentali, il finto
cordoglio delle autorità, le promesse di un intervento rapido e
definitivo e… arrivederci al prossimo anno ed all’immancabile,
ipocritamente imprevisto, disastroso allagamento.
I napoletani, noti per la loro capacità di improvvisazione, ed alla
costante ricerca di mezzi di sostentamento, pensarono bene di trarre
qualche vantaggio anche dalle calamità naturali e dall’incuria dei
loro amministratori ed inventarono un nuovo mestiere: il Passalave.
Per descrivere tale mestiere, è opportuno precisare che l’allagamento
dovuto all’afflusso dell’acqua proveniente dalle colline non era una
prerogativa dei soli Vergini, ma anche delle strade che si trovano a
valle della collina di San Martino e del Corso Vittorio Emanuele tra
le quali la ben nota via Toledo che, alle prime piogge, si tramutava
in un autentico torrentello.
Questa centralissima via, però, a differenza della Sanità e delle
Fontanelle, era, ed è, una strada frequentata da persone abbienti e da
uomini d’affari che non gradivano di insozzare scarpe e pantaloni per
passare sull’altro marciapiede.
Per tale motivo, numerosi uomini del volgo, improvvisatisi facchini,
con pantaloni rimboccati, aiutavano ad attraversare la strade chiunque
facesse loro dono di una mancia adeguata.
In quale modo?
Ma a cascecauoglio, ovvero in groppa.
Questi facchini si chiamavano Passalave e, viste le condizioni
delle fogne partenopee, potrebbero eserc8itare ancora oggi, e con
profitto, il loro onorato mestiere. |
|
'O LUTAMMARO
Le diatribe concernenti i prodotti
geneticamente modificati riempiono, da parecchio tempo, le pagine dei
giornali.
Polemiche, anatemi, scomuniche, domande senza risposte, pareri non
richiesti, pareri richiesti e non ottenuti.
Molti, autorevoli studiosi sostengono che la diffusione di tali
prodotti può sconfiggere definitivamente la fame nel mondo mentre
un’altra schiera di studiosi, ugualmente autorevole ed agguerrita,
profetizza immani sciagure e prospetta scenari raccapriccianti.
Tutto questo in un susseguirsi di scandali e di sconvolgenti
rivelazioni relative ad animali “gonfiati” chimicamente, ad estrogeni
somministrati senza risparmio a polli, mucche e maiali, macellati e
messi in commercio senza che le loro zampe, o i loro zoccoli, abbiano
mai calpestato un prato o una stalla.
Industrie con bilanci di migliaia di miliardi si sono specializzate
nella fabbricazione di magici concimi e miracolose misture che
consentono di produrre autentiche mostruosità e provocare un numero di
fioriture fino a pochi anni fa impensabili.
Piccoli appezzamenti di terreno, opportunamente coperti di teli di
plastica e trasformati in autentiche serre, producono oggi un raccolto
fino a pochi anni fa inimmaginabile.
Tutto ciò in cambio di cibi insipidi e stopposi e di verdure viscide e
dal sapore indefinibile.
Cibi che causano l’insorgere di nuovi malanni curati con nuovi
medicinali prodotti da nuove industrie che effettuano nuove ricerche
finanziate con nuovi fondi che…
Devo continuare?
Quando ero ragazzo, una bistecca di maiale rigirata in padella
profumava l’intero condominio ed una mela annurca, magari beccata da
un uccello o intaccata da un insetto, sostituiva degnamente un’intera
confezione di vitamina C.
Allora si usavano sistemi (umani), i maiali mangiavano ghiande e mele,
le mucche brucavano nei campi ed i pomodori si cominciavano a mangiare
a giugno.
Fino a pochi anni fa, per fertilizzare la terra e per fare dei buoni
raccolti, si adoperavano sistemi tradizionali, tramandati di padre in
figlio, e l’unico concime conosciuto era il letame.
Fino a pochi anni fa c’era ‘o lutammaro.
Questo mestiere, oggi improponibile, trovava largo impiego
in quanto veniva fatto un uso abituale di animali da traino e da soma.
Il lutammaro raccoglieva
nelle strade, nelle stalle e nelle masserie gli escrementi degli
animali ed in particolare la lutamma per rivenderla a basso
costo come concime.
Veniva chiamata lutamma la paglia infradiciata nelle stalle
sotto gli animali dove si mescolava con la loro urina e con i loro
escrementi.
Spesso il
Lutammaro
veniva anche in città, attratto dai luoghi dove stazionavano le
carrozzelle, dai mercati generali e dai mercatini rionali dove
sostavano carrette trainate da cavalli ed asini che rappresentavano
per lui un’ottima fonte di guadagno.
Da ragazzo, al Borgo Sant’Antonio
Abate, alla Sanità e ai Vergini, mi è capitato di assistere ad
autentiche, sanguinose risse tra lutammari che cercavano di
estromettersi a vicenda e che si disputavano il “diritto allo
sfruttamento del territorio”.
Fatto che induce ad amare riflessioni sulla miseria, oggi impensabile,
allora accettata e sopportata con disperata e bovina rassegnazione. |
|
|
|
'A PIZZA OGGI AD
OTTO
Il Vico Minutoli è stato, in due
momenti diversi, il microcosmo al quale sono appartenuto e nel quale
mi sono formato.
E’ un vicolo stretto – all’epoca mi sembrava larghissimo! – che,
partendo da via Giuseppe Piazzi, termina in via Michele Tenore. Credo
che Giuseppe Piazzi sia stato un astronomo e che Michele Tenore sia
colui che ideò e realizzò l’Orto Botanico.
Questi due nomi, però, valgono ben poco per gli abitanti della zona
che continuano a chiamare le due strade, rispettivamente, Vico
Saponari e Salita di Santa Maria degli Angeli.
Sapunaro,
in napoletano, vuol dire rigattiere, e quindi, dal nome quasi
premonitore, si può facilmente desumere il tipo di società, il livello
culturale ed il grado di civiltà degli abitanti della zona.
In quegli anni, però, era una
stradina tranquilla ove gli abitanti costituivano una vera comunità e
si sentivano affratellati e partecipi dei problemi e delle vicende di
tutti.
I bassi si animavano alle prime luci dell’alba e un popolo variopinto
si riversava nella casa comune, che si trasformava all’istante in un
gigantesco palcoscenico.
Senza copione e senza regista, ma con antica ed innata bravura, si
improvvisava la commedia giornaliera con attori pronti, di volta in
volta, a cambiare il loro ruolo sicchè, da protagonista, si diventava
disinvoltamente comprimari o semplici comparse.
Non mancavano il guappo, la prostituta ed il femmeniello, ma
tutti avevano una loro logica collocazione ed una specifica funzione
nel variopinto tessuto di una società antica e saggia, scanzonata e
cialtrona, miscredente e devota.
L’edicola sacra raffigurante un’ingenua Madonna era, infatti,
abbellita da luci e fiori artificiali, ma i bisognosi ricorrevano
indifferentemente a Lei o a don Giovannino, che abitava in un basso
situato all’angolo del vicolo e che godeva fama d’ineguagliabile
guaritore e di potentissimo iettatore (letteralmente menagramo.
Era, in verità, una figura composita: ciarlatano, guaritore,
fattucchiere e, in molti casi, consigliere).
Non era raro vedere al capezzale di un infermo l’immagine della
Madonna, il cuore di Gesù ed un gigantesco corno: i rimedi devono
essere sperimentati tutti!
Dal vicino Orto Botanico e dalle stradine che provenivano dai Ponti
Rossi e da Capodimonte giungeva a folate un venticello lieve come un
respiro che, con l’arrivo della primavera, portava profumi d’erba
tagliata e di precoci viole misti all’odore salmastro proveniente
dalle spiagge nerastre, per la spiaggia di origine vulcanica che per
secoli il Vesuvio ha riversato nel Golfo e sulla città.
Molto spesso tali profumi erano soverchiati dall’odore del caffè,
tostato sulla soglia di un basso in un cilindro affumicato, utilizzato
con secolare perizia, che ruotava sopra la fornacella.
In quegli anni il caffè era un piacere per soli ricchi. Agli abitanti
dei vicoli era riservato il più modesto orzo e solamente l’odore
proveniente da quel magico cilindro. I popolani, però, non si
rassegnavano a questa tortura e, appena potevano consentirselo,
gustavano con religiosa concentrazione il vero caffè, pervenuto chissà
tramite quali canali.
Questa prelibatezza era venduta in piccole coppette di carta, ‘e
cuppetielle, che diventavano una vera tentazione per i buongustai
nauseati dalla brodaglia scura ottenuta con l’autarchico orzo o
ricavata dalle ancora più disgustose chichierchie (specie di
lenticchie che erano abbrustolite).
Uno spettatore attento avrebbe potuto stabilire, dagli odori che si
propagavano nel vicolo cosa avrebbe mangiato don Vincenzino o che cosa
donna Clorinda, la capera, stava approntando per la sera.
Ogni famiglia aveva le sue specialità, ogni basso il suo “artista” del
quale il popolino non mancava di sottolineare pregi e virtù, in modo
colorito ed efficace.
Per anni ho sentito parlare, infatti, della pasta e piselli di donna
Concetta, delle alici indorate e fritte di Carmelina, del ragù di
Filomena ‘a chiattona.
Oggi la cultura del vicolo è svanita, quella società che ti adottava e
ti faceva crescere circondato da affetto e di ruvida allegria, che ti
faceva sentire in un utero materno, si è trasformata in un’accozzaglia
di individui eterogenei, protesi a risolvere i propri problemi da soli
ed a scapito di tutti.
Oggi i vicoli brulicano di extracomunitari e di gente di colore che
nulla conoscono della granitica fusione degli abitanti dei bassi, di
quella gente che insieme rideva e insieme soffriva.
Chi aveva una incartata di pasta la divideva col vicino, l’olio di uno
era l’olio di tutti, bambini e scugnizzi avevano cento madri e cento
padri.
I commercianti erano rassegnati a riscuotere i chilometrici debiti del
vicolo a scadenze… indeterminate. Il latte fresco per i bambini,
tutto veniva elargito senza troppe difficoltà, rinviando il pagamento
a tempi migliori!
C’era la pizza oggi ad otto!
Ne ha parlato, tanto per cambiare, Giuseppe Marotta, originario del
mio quartiere e quindi buon conoscitore del microcosmo che mi ha
forgiato.
Don Rafele, il pizzaiolo, si aggirava di primo mattino con un capace
ruoto, opportunamente coperto, sul capo, urlando il suo ben noto
richiamo. Da quel magico ruoto si diffondeva nel vicolo un magico
effluvio che solleticava lo stomaco risvegliando famelici appetiti:
l’odore delle pizze con la ricotta.
L’odore delle pizze appena fritte su una improvvisata fornacella messa
sulla soglia del suo basso e curate con cura e perizia da sua moglie,
la giunonica donna Concetta che, circondata da una turba di scugnizzi
e comari prodighe di suggerimenti, non negava a nessuno l’assaggio
tentatore.
Un autentico supplizio di Tantalo!
E se non si possedevano i pochi spiccioli necessari per acquietare i
disperati appelli dello stomaco sollecitato da irresistibili
tentazioni?
Nessun problema: una pizza con ricotta non si nega a nessuno!
Pagamento oggi ad otto, vale a dire tra otto giorni.
Promozione e sistema di vendita plagiato oggi da alcuni negozi che
promettono pagamenti dilazionati a tasso zero (a cui credete
veramente?) e versamento della prima rata tra sei mesi o a partire
dall’anno prossimo.
Garanzie, firme, anticipi?
Macchè, scherziamo?…
A don Rafele bastava la parola. E, nei lunghi anni nei quali ho fatto
parte di quel mondo, non ho mai sentito raccontare di una pizza non
pagata o pagata in ritardo! O, se è accaduto, don Rafele si è ben
guardato dal diffondere una notizia che avrebbe scalfito, con quella
del suo insolvente creditore, la sua stessa immagine.
La pizza con la ricotta, come il babà, è una cosa seria!
E poi, non era conveniente chiudere definitivamente una porta e
tagliare i ponti con un piacere che, spesso, rappresentava l’estrema
risorsa, l’unico pasto della giornata.
A tali motivi, che potremmo definire utilitaristici o pragmatici, se
ne aggiungeva un altro che, rispettato fino a qualche anno fa, è
finito oggi nel dimenticatoio: l’ommo p’a parola e ‘o voio p’e
corna! (l’uomo si giudica dalla parola ed il bue dalle corna!). |
|
|

 |